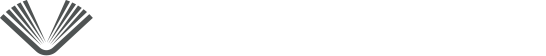La nuova informazione parlamentare che ci si appresta a rivedere al rialzo il limite dell’utilizzo del contante, oltre a sollevare le scontate discussioni tra chi è favorevole e chi è contrario alla specifica misura, fa riflettere su come questo modo alternato di affrontare la questione determini incertezza in chi deve osservare l’obbligo e in chi sull’obbligo deve sviluppare una concreta azione di contrasto a specifici fenomeni di evasione fiscale ovvero di criminalità. Nel caso specifico forse il problema che si crea non è in termini di certezza del diritto (argomento di stretta attualità) ma di coerenza del legislatore che, oramai da oltre 5 anni ha intrapreso una strada e un percorso integrato per ridurre l’utilizzo del contante a favore di mezzi di pagamento tracciabili.
Alla decisione di rialzare il limite del contante, infatti, non si oppongono impegni o obblighi imposti a livello internazionale, ma si oppongono le scelte volontarie realizzate in termini normativi, regolamentari e interpretativi, fatte dallo Stato e dai suoi apparati sotto bandiere diverse.
Teniamo conto i numerosi provvedimenti che hanno negli ultimi anni introdotto regole di incentivo a chi utilizza mezzi di pagamento tracciabili rispetto alla moneta contante. A titolo di mera esemplificazione si consideri il Decreto che in questi giorni è in discussione alle commissioni finanze e bilancio del parlamento per l’attuazione dell’art. 9 della delega fiscale in cui l’utilizzo di mezzi tracciabili in luogo del contante riduce di un anno i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Ovvero si consideri i provvedimenti che entro la fine del 2015 imporranno a tutti gli enti pubblici l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronico. Ovvero, ancora, l’onere introdotto per i commercianti di mettere il cliente nella possibilità di pagare mediante una carta di debito.
Queste scelte hanno portato già alcuni effetti e ne porteranno in futuro, facendo cambiare alcune abitudini invalse nella nostra società solo se la misura verrà costantemente mantenuta e ribadita. Ovviamente se la decisione contraria prevarrà ci si auspica che nell’incoerenza si scelga in modo definitivo quale sia la strada da seguire. In altre parole, quello che si chiede al legislatore è che una scelta contraria sia presa in coerenza con una nuova strategia d’insieme che venga ben spiegata al cittadino e al funzionario pubblico. Al contrario, sarà solo la dimostrazione che nel nostro Paese le scelte sono sempre e comunque emozionali e non strutturali.