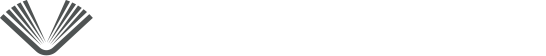Nell'ambito delle politiche di gruppo in materia di prezzi di trasferimento merita una particolare attenzione la determinazione dell'arm's length price con riferimento a quelle società del gruppo che vengano a trovarsi in una situazione di c.d. "perdita sistemica”. Sul punto, infatti, potrebbe esservi una particolare attenzione dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica, in quanto la stessa potrebbe ritenere che tale situazione possa essere indotta, non da motivi economici contingenti, ma da una inappropriata policy di transfer pricing. È pertanto rilevante, in tali situazioni, per i gruppi multinazionali dimostrare, in primis, che le perdite in questione sono effettivamente imputabili a problematiche di natura industriale e, successivamente, la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento intercompany. Tale modus operandi è in perfetta sintonia con quanto previsto dalle Linee Guida OCSE, le quali non ammettono una rettifica automatica dei prezzi intercompany in caso di “genuine perdite ricorrenti”, ma, appunto, segnalano la necessità di una previa attenta verifica delle ragioni delle perdite stesse, essendo ben possibile che le ripetute perdite nel tempo possano trovare ragione in vincoli di natura politica o sociale, ovvero essere determinate da cause di obsolescenza e/o di inefficienza della produzione. Per quanto poi attiene al miglior metodo utilizzabile per la quantificazione dei prezzi di trasferimento nel caso in esame, deve essere subito sgomberato il campo dalla posizione spesso assunta dall'amministrazione finanziaria circa l'inutilizzabilità del CUP (comparable uncontrolled price). Infatti, i diversi metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento hanno quale scopo quello di individuare il cd. “metodo più appropriato” in relazione alla specifica transazione, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascuno, della natura delle transazioni intercompany, della disponibilità di informazioni affidabili per la corretta applicazione del metodo e del grado di comparabilità tra le transazioni intercompany e quelle effettuate tra parti indipendenti. Pertanto, se è pur vero che le Linee Guida OCSE non prevedono più una cd. “gerarchia dei metodi” per la determinazione dei prezzi di trasferimento, d’altro canto è altrettanto vero che i cd. “metodi tradizionali” rimangono quelli da preferire e tra questi, primo fra tutti, è proprio il CUP, a parità di condizioni. Vale poi ricordare come la stessa Agenzia delle Entrate, nel commento alla disciplina sugli “oneri documentali” di cui all’art. 26 del D.L. 78/2010, precisa che qualora dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transnazionale reddituale e, in maniera egualmente affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (tra i quali rientra il CUP), l’utilizzo di tale ultimo metodo sarebbe non solo da preferire, ma qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in ipotesi applicabile, lo stesso sarebbe tenuto a fornire adeguate motivazioni di tale scelta. Deve dunque concludersi che in caso di perdite ripetute, una volta comprovato che le stesse non sono frutto di policy di transfer pricing, bensì di inefficienze economiche, le perdite in questione non devono essere necessariamente imputate alla casa madre, ma occorre che siano prese nella debita considerazione ai fini della individuazione del metodo più appropriato per l'individuazione dell'arm's length price. Del tutto arbitrario sarebbe, infatti, in tali circostanze l'utilizzo del metodo del TNMM (Transactional net margin method), al solo scopo di assicurare alla società verificata un margine di profitto comunque positivo, a discapito delle comprovate perdite sofferte medio tempore.
Perdite sistematiche da dimostrare
24 giugno 2015