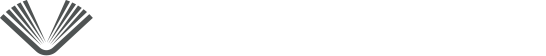di Benedetto Santacroce e Michele Procida
Il disegno di legge delega n. 2681, approvato definitivamente al Senato, indica i princìpi e i criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo, per dare attuazione alla riforma organica delle procedure concorsuali, della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, e con riferimento all’oggetto della presente analisi, la legge delega conferma e sviluppa la scelta, già manifestata per le imprese dal legislatore con l’art. 182-ter della legge fallimentare, di superare il principio di indisponibilità dei crediti tributari, al fine di consentire una soluzione negoziale della crisi di impresa.
In una realtà in cui le imprese manifestano sempre più frequentemente una rilevante esposizione debitoria proprio verso il Fisco, garantire un’ampia flessibilità alle decisioni dell’Erario, attraverso la valorizzazione degli strumenti transattivi, diviene l’unica via percorribile al fine di migliorare l’efficacia stessa dell’attività di riscossione dei tributi, nella consapevolezza che la mancanza di condizioni che consentano al debitore di superare la situazione di crisi determinerebbe un danno anche per gli interessi erariali.
La possibilità di un pagamento parziale dei debiti tributari era finora attivabile solo in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-ter, legge fallimentare. Con la legge delega in commento, invece, viene ammessa la facoltà, per il debitore, di accordarsi con il Fisco anche al di fuori di una procedura giudiziale e perfino in una fase di pre-crisi.
Più nel dettaglio, l’art. 4 della legge delega introduce una fase preventiva e stragiudiziale, diretta ad anticipare l’emersione della crisi e ad agevolare una risoluzione dello stato di difficoltà, prima che esso possa deteriorarsi ulteriormente, attraverso un servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento di un accordo tra il debitore e il creditore, accordo che, appunto, può avere ad oggetto anche i debiti nei confronti del Fisco.
La procedura di allerta e composizione della crisi si svolgerà con l’assistenza di un organismo di composizione, appositamente istituito (art. 4, lett. b), e potrà essere attivata su istanza del debitore oppure su segnalazione obbligatoria dei creditori pubblici qualificati, -tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate- qualora ravvisino il perdurare di inadempimenti di importo rilevante (art. 4, lett. d).
Secondo le disposizioni della legge delega, il rapporto con l’Erario potrebbe addirittura essere definito mediante un accordo che intervenga anteriormente e al di fuori della procedura di allerta, in una fase ulteriormente anticipata di trattative con il fisco.
È infatti previsto, dalla citata lett. d) dell’art. 4, che l’Agenzia delle Entrate avvisi immediatamente il contribuente se la sua situazione debitoria superi l’importo rilevante. Il debitore, a quel punto, ha tre mesi di tempo per: ●estinguere il debito; ●chiedere l’ammissione ad una procedura concorsuale; ●attivare il procedimento di composizione assistita della crisi; ●raggiungere un accordo con il creditore pubblico qualificato. Solo in mancanza di tali esiti, l’Agenzia delle Entrate avrà l’obbligo, il cui mancato adempimento è sanzionato con la perdita del privilegio che assiste il credito tributario, di segnalare la situazione di insolvenza all’organismo di composizione.
Inoltre, il legislatore delegato dovrà introdurre a favore del debitore che tempestivamente attivi la procedura di allerta o si avvalga di uno degli altri istituti di composizione concordata della crisi, tra le altre, una misura premiale consistente in una congrua riduzione delle sanzioni e degli interessi correlati ai debiti fiscali (art. 4, lett. h).
Naturalmente occorrerà attendere che il Governo recepisca questi princìpi e criteri direttivi in uno o più decreti legislativi -ha dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge delega- per valutarne la portata innovativa. Ad oggi, dunque, per le imprese l’unico spazio consentito per una transazione fiscale rimane quello delineato dall’art. 182-ter della legge fallimentare, ma in futuro sarebbe possibile una sua estensione, con l’introduzione della possibilità di accordarsi con il Fisco in via stragiudiziale.