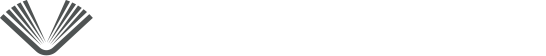Benedetto Santacroce
Anna Abagnale
Gli studi di settore escono quasi indenni dalla valutazione di compatibilità rispetto alla normativa Iva della Corte di Giustizia. In particolare, con la sentenza relativa al caso Fontana (causa C-648/16), i giudici europei hanno chiarito che non è in contrasto con la Direttiva Iva, né con i principi di neutralità e proporzionalità, la normativa italiana che consente all’Amministrazione finanziaria, al fine di accertare l’effettivo volume d’affari realizzato dal contribuente, di ricorrere all’accertamento induttivo basato sugli studi di settore, qualora riscontri gravi divergenze tra i redditi dichiarati e quelli stimati sulla base degli stessi.
Affinché la rettifica fiscale che determina l’imposizione di una maggiorazione dell’Iva sia legittima è necessario che allo stesso contribuente sia permesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare le risultanze derivanti da tale metodo ed esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga.
Dunque, studi di settore ammessi per il recupero di una maggiore Iva, ma non senza condizioni. La pronuncia della Corte si pone a chiusura di un percorso che ha inizio con la denuncia dell’AIDC del 15 aprile 2011. In quell’occasione i dottori commercialisti avevano sostenuto che un recupero dell’Iva realizzato non sulla base delle effettive operazioni effettuate, bensì sulla base di un ricalcolo del volume d’affari con criteri statistico-matematici, violasse innanzitutto le norme unionali che impongono che la base imponibile Iva sia determinata in modo oggettivo ed effettivo sulle singole transazioni realizzate dall’operatore economico; in secondo luogo, fosse in contrasto con i precedenti della Corte di Giustizia sul tema del calcolo dell’Iva esclusivamente sulla base del corrispettivo realmente ricevuto e «non già sulla base di un valore stimato secondo criteri obiettivi» (CGUE, sentenza causa C-258/95).
La critica, non condivisa dalla Commissione europea, aveva permesso alla norma di sopravvivere nell’ordinamento domestico, finché con il caso Fontana essa è ritornata all’attenzione.
Il primo chiarimento della Corte di Giustizia riguarda la legittimità della norma interna che determina l’importo dell’Iva dovuta da un soggetto passivo sulla base del volume d’affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali approvati con decreto ministeriale. La ratio è quella di garantire l’esatta percezione dell’Iva e di prevenire l’evasione fiscale. Tuttavia, secondo la Corte – ed e questo il dato interessante – sia la norma che la sua applicazione devono rispettare i principi di neutralità dell’imposta, di proporzionalità e il diritto di difesa.
Nello specifico, in relazione al caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad una rettifica dell’Iva, il cui importo risulti da un maggior volume d’affari complessivo accertato induttivamente, il principio di neutralità sarebbe rispettato solo se il soggetto passivo accertato possa detrarre l’Iva assolta a monte. Quanto al principio di proporzionalità, non vi sarebbe violazione se la rettifica fiscale risulti basata su studi di settore esatti affidabili e aggiornati, con la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria. Ed, infine, affinché non sia leso il diritto di difesa del contribuente, è necessario che gli sia garantita la possibilità di contestare tanto l’esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore in questione. In altre parole, il contribuente deve essere sempre messo nella condizione di poter far valere le circostanze per cui il volume d’affari dichiarato, anche se inferiore a quello determinato in base al metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo accertato. In caso contrario, il recupero della maggiore Iva sarebbe di certo illegittimo.