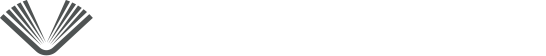Arte e fisco due mondi caratterizzati da una forte incompatibilità di base che ciclicamente determina piccoli e grandi conflitti che possono trovare soluzione attraverso un radicale mutamento del paradigma di riferimento. Non è, infatti, possibile pensare che la normativa fiscale possa seguire e inseguire, con i propri rigidi schemi lo sviluppo incessante e improvviso dell’arte.
L’arte è un mondo caratterizzato dalla creatività dell’artista che è influenzato solo da ciò che lo circonda senza alcuno schema predefinito. In questa sua libertà espressiva l’artista nel tempo ha creato e continua a creare le sue opere utilizzando gli strumenti e la tecnologia disponibili nella società in cui vive.
Anche la figura dell’artista nel tempo è notevolmente mutata perdendo, in alcuni casi la sua individualità ovvero sostituendo la sua manualità a quella di tecnici e artigiani che sono in grado di realizzare l’idea o il progetto da lui pensato e concepito.
La normativa fiscale, al contrario, perseguendo finalità quali la certezza del diritto, la neutralità fiscale, la capacità contributiva del contribuente e la corretta percezione delle imposte, vorrebbe riuscire a riclassificare tutti i fenomeni umani in rigidi schemi che consentano di definire esattamente la categoria reddituale o il prelievo da applicare ad ogni singola manifestazione di ricchezza o di reddito. Inoltre, in questo sforzo di standardizzazione bisogna tenere ben presente, specialmente nel mondo delle imposte indirette, i meccanismi tecnici che informano le singole transazioni che consentono all’opera d’arte di trasferirsi dall’artista al collezionista attraverso le diverse figure di intermediazione.
È chiaro che questa incompatibilità di base tra i due mondi non mediata da agili strumenti di adeguamento, ma affidata alle lente procedure regolatorie e a rigidi schemi interpretativi genera nel tempo alcuni cortocircuiti. L’ultimo in ordine di apparizione l’abbiamo avuto nel mondo dell’Iva dove il fisco è stato chiamato a valutare l’applicabilità o meno dell’aliquota agevolata del 10% su un oggetto che creato e progettato da un artista era, nella sua versione “grezza”, prodotta attraverso l’utilizzo di software e stampanti 3D. In effetti, nel caso di specie dopo la stampa l’artista modificava l’oggetto con diversi interventi manuali (risposta 303/E/2020).
Il fisco nel caso di specie, disattendendo la richiesta del contribuente, e statuendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria argomentava la sua posizione sulla base del testo della norma di riferimento che puntualmente definisce, ai fini dell’aliquota agevolata, “le opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista ovvero le fusioni di scultura a tiratura limitata ad otto esemplari controllata dall’artista”.
La norma perseguendo i criteri suddetti di certezza del diritto e neutralità fiscale supera ogni concetto di merito sul contenuto artistico del prodotto (cercando di eliminare ogni valutazione discrezionale), ma si affida ad un contenuto oggettivo che definisce l’opera in base all’intervento dell’artista o meglio, come specifica la Corte di giustizia – C-148/18, dell’autore. Quindi, il termine “interamente”, come si comprende meglio nel caso delle fusioni va inteso quale controllo totale e, in particolare, finale, da parte dell’autore. Il tema è distinguere l’opera dell’autore dal prodotto di massa per il quale l’autore ne perde il controllo.
Quindi è chiaro che la tecnica con cui è prodotto (analogica o digitale) non può influenzare l’applicazione del regime dell’aliquota ridotta. Inoltre, non si può assolutamente disconoscere che la creazione artistica (d’autore) ideata e progettata dall’artista utilizzando software e, nel caso di specie, stampanti 3D non possa essere ricondotta interamente all’artista che l’ha ideata e progettata. Questo perché nello sviluppo dell’arte la manualità dell’artista è stata via via sostituita con la capacità dello stesso di ideare l’opera e di realizzarla attraverso l’intervento di artigiani e tecnici capaci di rendere possibile la trasformazione dell’idea in oggetto. Nell’arte lo sviluppo di installazioni complesse o realizzate su differenti supporti richiede sempre di più alcune conoscenze tecniche e matematiche che necessitano di differenti competenze che l’artista trova in terze persone. In effetti a dire il vero questo fenomeno è meno recente di quanto si possa pensare.
Allora è chiaro che le strade su cui ci si può muovere sono particolarmente strette e tortuose, e si ritiene che, se da una parte, la norma deve essere sempre interpretata in modo adeguato alla realtà e allo sviluppo tecnologico per non creare distorsioni nel mercato, dall’altra è necessaria una più profonda riflessione che consenta all’arte in quanto tale di essere premiata e agevolata cambiando il paradigma di riferimento. In questo senso, gli sforzi possibili dovrebbero portare a ridefinire le norme, cercando, come si fa in altri campi, di trovare nell’arte stessa e nella sua evoluzione i punti fermi che caratterizzano e differenziano un’opera d’arte da un oggetto di produzione di massa.