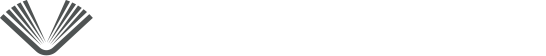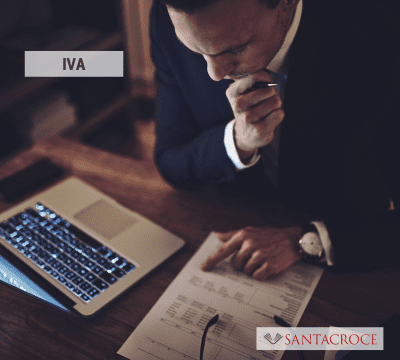La dichiarazione di incompatibilità della disciplina nazionale delle società di comodo con la direttiva Iva, comporta l'analisi e la revisione di tutti i rapporti ancora pendenti con effetti immediati su accertamenti e contenziosi.
Con la sentenza C-341/22, i giudici europei interpretano le norme della direttiva Iva (articolo 9 e 167) nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, i.e. l'articolo 30 della legge 724/1994, che, al verificarsi di determinate condizioni - le quali appunto non trovano giustificazione nel diritto unionale - limitano il diritto alla detrazione del contribuente.
In altre parole, la disposizione sulle società di comodo viene valutata definitivamente non conforme al diritto dell'Unione. In tali circostanze, ci si aspetta che il legislatore agisca con tempestività e proceda ad eliminare il motivo di contrasto con il diritto sovraordinato, abrogando la norma in questione.
Ma quali sono nell'immediato gli effetti della pronuncia e quali impatti potrebbe avere su questioni analoghe? È pacifico che la Cassazione, quale giudice a quo, dovrà applicare le norme della direttiva coinvolte secondo il signifivato e la portata attribuitale dalle Cgue, disapplicando l'articolo 30 della legge 724/1994 che, alla luce dell'interpretazione resa, si prospetta in contrasto con la stessa. Da ciò conseguendo, riguardo alla fattispecie concreta, l'accoglimento del ricorso presentato dalla contribuente e il riconoscimento del diritto alla detrazione.
Ma, data la rilevanza esterna della sentenza pregiudiziale interpretativa, all'accertamento del contenuto della norma Ue dovrebbe seguire l'obbligo per qualunque organo dello Stato, giudice o amministrazione, di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma unionale individuata nei suoi contenuti (senza che sia necessaria un'istanza di parte: Cgue, sentenza C-358/95).
Sul piano temporale, l'interpretazione della Corte, chiarendo il significato delle norme Ue sulla soggettività passiva Iva e sul diritto alla detrazione quale avrebbe dovuto essere inteso sin dal momento della loro entrata in vigore, non può che avere effetti retroattivi. Sicché si ritiene inevitabile che tale sentenza produca degli effetti anche in relazione a tutti i rapporti sorti anteriormente ad essa, purché esauriti (Cgue, sentenza C-127-128/79).
Va ricordato che, solo in via eccezionale la Corte di giustizia si riserva, espressamente, la possibilità di limitare gli effetti nel tempo delle proprie pronunce pregiudiziali. Ciò avviene nei casi in cui ritiene che la retroattività implicherebbe il rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa nazionale fino ad allora ritenuta valida nonché il rischio di incertezza giuridica. In quest'occasione non sembra che la Corte abbia valutato una tale limitazione.