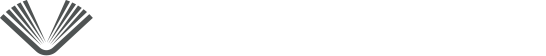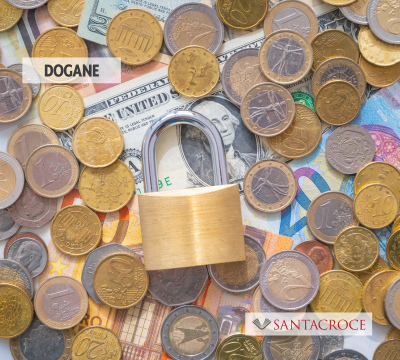Il decreto delegato di riforma del diritto doganale interno ha cominciato il 18 giugno scorso il suo percorso per l’ottenimento dei relativi pareri. Il testo che approda al Parlamento presenta alcune importanti criticità che dovranno essere debitamente valutate per evitare che la sua approvazione definitiva senza modifiche possa portare, agli operatori economici interessati, degli effetti del tutto indesiderati rispetto anche ai principi imposti ad agosto 2023 dalla legge delega (legge 111/2023), e alle amministrazioni preposte al controllo, la creazione di procedimenti inutili e del tutto sproporzionati rispetto ai diritti tutelati.
Le principali criticità riguardano la modulazione delle sanzioni penali e amministrative, le regole di applicazione dell’istituto della confisca sia sul piano penale che amministrativo, la formulazione dell’articolo 27 delle disposizioni complementari del Codice doganale, che identificano i diritti di confine con inclusione esplicita dell’Iva.
In questa sede mi limiterò ad analizzare come la modalità con cui sono state costruite le sanzioni penali del contrabbando portano al non rispetto assoluto del principio di proporzionalità ma, cosa più che grave, comportano una forte discriminazione tra sanzioni penali tributarie interne e contrabbando.
In effetti, gli articoli 78 e 79 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione prevedono due macro ipotesi di contrabbando in caso di omessa o infedele dichiarazione doganale. Queste due ipotesi di reato scattano in modo automatico nel caso i cui i diritti di confine omessi o indebitamente percepiti superino la somma di 10.000 euro (limite che, come dirò, non è assolutamente fissato in modo obbligatorio dalla Ue).
Più in particolare, per spiegare meglio il mio pensiero e per dimostrare il non rispetto della proporzionalità mi concentrerò, partendo da un caso specifico, sull’ipotesi di infedele dichiarazione previsto dall’articolo 79 delle predette disposizioni.
Il caso che voglio considerare è quello di un operatore che sbagli l’indicazione di un codice di nomenclatura combinata e, in relazione a tale errore, superi in termini di dazio ovvero di Iva la soglia dei 10.000 euro.
In tale situazione, scatta l’ipotesi prevista dall’articolo 79 delle disposizioni complementari del Codice doganale unionale. Che prevede che chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
Il limite da cui scatta la sanzione penale si determina in ragione del combinato disposto dell’articolo 88 e 96 delle stesse disposizioni complementari. In particolare, in senso positivo, l’articolo 88 (circostanze aggravanti del contrabbando) prevede al comma 2 e 3 che, per il delitto di contrabbando, alla multa è aggiunta
- la reclusione fino a 3 anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- la reclusione da 3 a 5 quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.
In senso negativo, l’articolo 96 prevede che la sanzione amministrativa dal 100 al 200% non si applica nel caso in cui l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro.
Quindi il limite minimo per cui scatta il reato di contrabbando è di 10.000 euro.
Prima di trarre ulteriori considerazioni sullo specifico limite, ci preme evidenziare che lo stesso trova sicuramente spazio nella normativa unionale solo in ipotesi particolarmente gravi (frode o violazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione) e quale limite minimo per l’applicazione di un’ipotetica sanzione penale. In particolare, la direttiva Pif (Direttiva 2017/1731, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione) prevede, all’articolo 7, nei confronti delle persone fisiche, distinguendole dalle persone giuridiche, il limite minimo dei 10.000 euro, limite che pur costituendo la soglia al di sotto della quale il legislatore può introdurre una sanzione amministrativa, va letto in modo sistematico alla luce dei considerando che accompagnano il provvedimento unionale. Nei considerando, infatti, il legislatore unionale chiarisce che:
- la sanzione penale scatta quando siamo in presenza di condotte fraudolente più gravi (considerando 3);
- in particolare, per le frodi carosello Iva ovvero la frode dell’Iva dell’operatore inadempiente, si considerano gravi quando è rilevante in più Stati membri e il danno causato sia almeno pari a 10.000.000 euro (considerando 18 e articolo 2 comma 2 della direttiva);
- i livelli di sanzione non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati (considerando 15);
- per le persone fisiche devono essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli considerati tali quando il valore è superiore a 100.000 euro (considerando 18 e articolo 7 paragrafo 3 secondo capoverso).
Un ulteriore provvedimento da considerare è la Direttiva 2024/1226, direttiva recentissima che disciplina le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione. Quindi violazioni particolarmente gravi. In questa direttiva risulta chiaro (con un approccio correttivo rispetto alla direttiva Pif) che il limite di 10.000 euro è il limite minimo sotto il quale il legislatore nazionale non può imporre misure penali.
Inoltre, il provvedimento prevede la possibilità per il legislatore di introdurre soglie diverse anche superiori al limite di 10.000 ovvero 100.000 euro in base alla gravità del fatto e di prevedere per le persone giuridiche sanzioni penali e non penali parametrate al fatturato. In particolare, per le violazioni relative all’importazione o esportazione di beni soggetti a restrizioni, la sanzione va parametrata al 5% del fatturato globale della persona giuridica ovvero un importo corrispondente a 40.000.000 euro.
Da quanto evidenziato sopra risulta già chiaro che le ipotesi considerate dal legislatore unionale non hanno nulla a che vedere con l’infedele dichiarazione doganale per l’utilizzo di una nomenclatura errata (il più delle volte per errore di natura interpretativa). Qui già a questo livello di analisi è chiaro che la scelta del legislatore nazionale va al di là di quanto richiesto dall’Unione e produce degli effetti indesiderati (creazione di un contenzioso penale del tutto irragionevole).
Oltre a quanto esposto in precedenza, la sproporzione della normativa doganale diventa ancora più chiara se la si confronta con l’ipotesi penale di infedele dichiarazione Iva prevista in caso di violazione che si realizzi al di fuori degli scambi extraUe. Infatti, l’articolo 4 del Dlgs 74/2000 prevede una sanzione penale con la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi quando il contribuente indica in una delle dichiarazioni annuali relative all’Iva elementi diversi da quelli effettivi quando congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
È chiaro, dunque, che l’approvazione dell’attuale schema di decreto delegato produrrebbe effetti discriminatori e non in linea con quanto richiesto dalla Ue, con la creazione di procedimenti penali del tutto sproporzionati che finirebbero in molti casi in archiviazione con il ripristino, in base all’articolo 96, comma 14, delle disposizioni complementari in esame, dell’applicabilità di sanzioni amministrative applicabili in presenza di colpa e non, come previsto dalle ipotesi penali, a titolo di dolo.
Per tornare alla sezione articoli