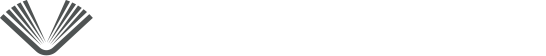L’intesa Usa-Ue offre lo spunto per alcune riflessioni di fondo sulla natura stessa del dazio doganale e sulla sua trasformazione, verrebbe quasi da dire mutazione, alla luce delle recenti evoluzioni che vedono gli Stati Uniti come assoluto protagonista della scena internazionale e su come vada concepito nelle strategie di impresa.
Cosa deve intendersi per dazio doganale avendo riguardo agli scopi e alle funzioni a esso associate? È ancora possibile interpretare una misura tariffaria secondo le sue due finalità storiche, vale a dire quella di generazione di gettito (prevalente leva fiscale) e/o quella di ombrello protettivo per taluni comparti produttivi interni meritevoli di attenzione (prevalente leva economica)? Ovvero dobbiamo invece riconsiderarla in maniera diversa e più ampia, alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi, come vero e proprio strumento negoziale ad ampio spettro nella dialettica internazionale per il riequilibrio dei saldi commerciali?
Quanto agli effetti che il nuovo scenario tariffario che va profilandosi produrrà nel medio e lungo periodo sulle economie mondiali è bene peraltro rifuggire dalla tentazione di arrischiare previsioni che potrebbero essere clamorosamente smentite dai fatti. Già nel 2018, all’indomani dell’adozione del primo pacchetto tariffario su acciaio e alluminio da parte della prima presidenza Trump (poi confermato anche dalla successiva presidenza Biden), era capitato a molti di declassare assai sbrigativamente i provvedimenti come dannosi nel medio termine per la stessa economia Usa e come tali destinati ad essere ritirati rapidamente: come sappiamo le cose sono andate diversamente. Va al riguardo considerato un ulteriore aspetto che contribuisce a complicare ogni tentativo previsionale. Nel corso degli anni (intendiamo degli ultimi settant’anni) abbiamo sempre misurato gli effetti e l’impatto di una determinata politica tariffaria analizzando delle «medie di dazi doganali», nella considerazione che a ciascun prodotto (meglio, a ciascuna linea tariffaria) potesse corrispondere un dazio assegnato, tarato in base all’impatto che il commercio di quel bene produce sull’economia del paese importatore e sulle aspettative fiscali che ne possono derivare. Oggi invece siamo di fronte ad un nuovo paradigma che va piano piano prendendo forma: nel caso dell’accordo Usa-Ue si ha ad esempio, lato Usa, un unico livello tariffario import (15%) spalmato su tutti i prodotti unionali (salvo eccezioni). Lo schema non cambia con riferimento a Paesi diversi dalla Ue, il dazio import in Usa può essere differente, ma sempre con carattere orizzontale (aliquota unica per tutte le merci salvo eccezioni).
Con buona pace del modello Wto e delle relative regole non discriminatorie, che formalmente ancora resistono, ma che appaiono nella sostanza agonizzanti, stiamo assistendo progressivamente a un radicale cambio di paradigma sulla scia della vigorosa spallata statunitense: da «un dazio per ciascun prodotto, a prescindere dal paese» nel quadro dello schema tradizionale Wto-Mfn (most favoured nation clause), a «un dazio per ciascun paese, a prescindere dal prodotto».
Di fatto una reale mutazione genetica del dazio doganale così come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi, che introduce nuove chiavi di lettura della dinamica commerciale internazionale e ci interroga sulla funzione sostanziale del dazio doganale in questa nuova configurazione e sulla rilevanza che il modello multilaterale Wto è in grado ancora di esprimere in questo momento storico.
Per tornare alla sezione articoli